Generoso Urciuoli – Responsabile della Direzione attività culturali e scientifiche del MegaMuseo Museo archeologico contemporaneo
Generoso Urciuoli, da dicembre 2024 è responsabile della Direzione attività culturali e scientifiche del MegaMuseo, ha assicurato la direzione del Museo Schneiberg di Torino e, dal 2008 al 2018, sempre a Torino, ha lavorato al MAO - Museo d’Arte Orientale come responsabile del settore mostre ed eventi e della galleria d'arte islamica.
MegaMuseo e territorio
Arrivo in Valle d’Aosta dopo un percorso che mi ha portato a lavorare all’apertura di musei sia pubblici che privati, mi sono quindi confrontato con approcci ed esigenze molto diverse.
Qui al MegaMuseo ho iniziato mettendomi subito in azione, sperimentando, cercando di perseguire l’inatteso, per capire come il pubblico, i valdostani, gli attori istituzionali potessero reagire. Viviamo il museo come hub culturale. Questa sperimentazione in qualche modo mi ha aiutato -e mi sta aiutando- a conoscere un po' il tessuto che caratterizza l'ambiente culturale.
Il MegaMuseo è inserito all'interno di un territorio e di un contesto molto specifici: è un sito archeologico che si è trasformato in un museo e racconta quindi in modo approfondito la storia di un luogo che appartiene a una comunità locale. Il problema è che questo approfondimento se per il visitatore esterno rischia di essere eccessivo, per la comunità in questione rischia di tramutarsi in disinteresse. In questo specifico caso, poi, il sito è stato un cantiere per decenni, ovvero qualcosa di non accessibile che ha “bloccato” e che è stato vissuto quasi come un elemento di disturbo. Alla luce di questi presupposti, c’è il bisogno di creare una sorta di “effetto simpatia” nei confronti del territorio, intendendo per territorio non solo quello cittadino. Su questo sito c’è stato un investimento molto forte da parte della politica che, in maniera lungimirante, ha deciso di salvaguardare e valorizzare le evidenze strutturali archeologiche.
Cultura come motore di sviluppo
Quello che ho percepito sin dai primi mesi è che la Valle d’Aosta, pur possedendo un patrimonio straordinario, non ha mai visto la cultura come un elemento realmente trainante. La natura, lo sport, l’enogastronomia hanno beneficiato di una valorizzazione più forte, mentre la cultura è rimasta spesso ai margini, quasi fosse la “cenerentola” dell’attrattività regionale. Eppure, i siti archeologici e del patrimonio culturale così come i musei locali custodiscono risorse capaci potenzialmente di attrarre l’attenzione internazionale; un esempio è l’abaco a bottoni, ritrovato nei corredi funerari, di cui ci sono solo tre esemplari al mondo!
Gli elementi di interesse non mancano ma per approfondire e indagare il nostro patrimonio dobbiamo metterlo in relazione con altri contesti, allargando gli orizzonti. Se voglio comprendere questo sito, devo metterlo a confronto con altre realtà, e non mi riferisco unicamente al sito di Sion, ma a tutto il megalitismo europeo e del vicino oriente. Un discorso analogo vale per la parte romana: la villa rustica e la necropoli ci restituiscono un quadro socio-economico “alto”: non si trattava dunque di un contesto periferico ma di un importante centro di attività. Abbiamo tutti gli elementi per attirare l’attenzione, suscitare l’interesse, stuzzicare la curiosità: dobbiamo però crederci.
L’elemento culturale può davvero diventare un fattore di sviluppo economico: ci sono tutti gli elementi perché questo non sia un semplice slogan, ma una realtà concreta. Questo cambiamento di prospettiva si deve basare sull’integrazione delle politiche. Non si tratta solo di relazione tra turismo e cultura, che nel contesto regionale dovrebbero di fatto essere una cosa sola, ma anche di integrazione tra cultura e istruzione, partendo dal sistema scolastico.
Oggi mi sembra che manchi un coordinamento strategico in questa direzione. Troppe attività si sviluppano senza una pianificazione condivisa, rischiando sovrapposizioni e dispersioni. E’ necessario far rete, fare sistema, guardare nella stessa direzione. Tavoli di lavoro permanenti e processi partecipativi sarebbero utili per programmare, costruire sinergie e garantire continuità. Questo richiede però anche che ciascun attore riconosca il ruolo di chi coordina, senza sentirsi scavalcato. Solo così la cultura può diventare un vero motore di sviluppo, e non un ripiego per le giornate di brutto tempo.
Tradizione, innovazione e qualità delle proposte
In Valle d’Aosta noto poi la presenza di una doppia anima: tradizione e innovazione. È un po’ come in Giappone, dove convivono elementi antichissimi e tecnologie avanzate. Qui però queste due anime spesso sembrano contendersi gli spazi e contrapporsi: da un lato la forte identità storica, dall’altro la voglia di sperimentare nuovi linguaggi. Per trasformare questa tensione in ricchezza serve un sistema culturale coeso, che proponga, come ho già detto, una visione comune.
Questa visione deve necessariamente muoversi verso la sperimentazione, l’apertura, bilanciando ricerca e divulgazione, offrendo chiavi di lettura accessibili senza banalizzare. Bisogna però superare la logica dell’evento per l’evento: ridurre la quantità e alzare la qualità è la strada più efficace, soprattutto in un territorio che non avrà mai i numeri delle grandi città. In questa logica è decisivo il rapporto tra qualità e comunicazione. In un’epoca di sovraccarico informativo, lanciare iniziative senza una strategia è inutile. Occorre avere il coraggio di ridurre la quantità, puntare su contenuti solidi e costruire narrazioni capaci di coinvolgere.
Non tutti sono disposti a investire tempo ed energie in musei ed eventi. Per ampliare i pubblici -al plurtale- occorre lavorare a monte, sul sistema scolastico, seminando la consapevolezza che la cultura non è solo pedagogia, ma anche benessere, welfare, occasione di crescita personale e collettiva. L’obiettivo è che i cittadini diventino ambasciatori inconsapevoli del proprio patrimonio, fieri di condividerlo con chi arriva da fuori.
Per questo credo sia necessario avvicinarsi a linguaggi più pop, popolari, senza però scadere nel trash. Dobbiamo sperimentare formati e strumenti che parlino a pubblici diversi, intercettando generazioni e sensibilità differenti. La dimensione ridotta della Valle può diventare un vantaggio: la prossimità tra operatori facilita il contatto, evitando ovviamente di degenerare in dinamiche chiuse o faziose. Sta quindi a noi trasformare la prossimità in risorsa, costruendo reti inclusive e consapevoli.
La Valle d’Aosta come laboratorio culturale
Sono convinto che questa regione abbia tutte le carte in regola per diventare un laboratorio interessante. La sfida è quella di portare la dimensione ridotta da limite a occasione di sperimentazione di modelli innovativi di governance culturale, di collaborazione tra pubblico e privato, di sinergia con turismo ed educazione. La cultura come sommatoria di tutti gli altri punti di forza – paesaggio, sport, enogastronomia – può diventare davvero il tratto distintivo della Valle d’Aosta, a patto di investirvi con serietà e visione a lungo termine.
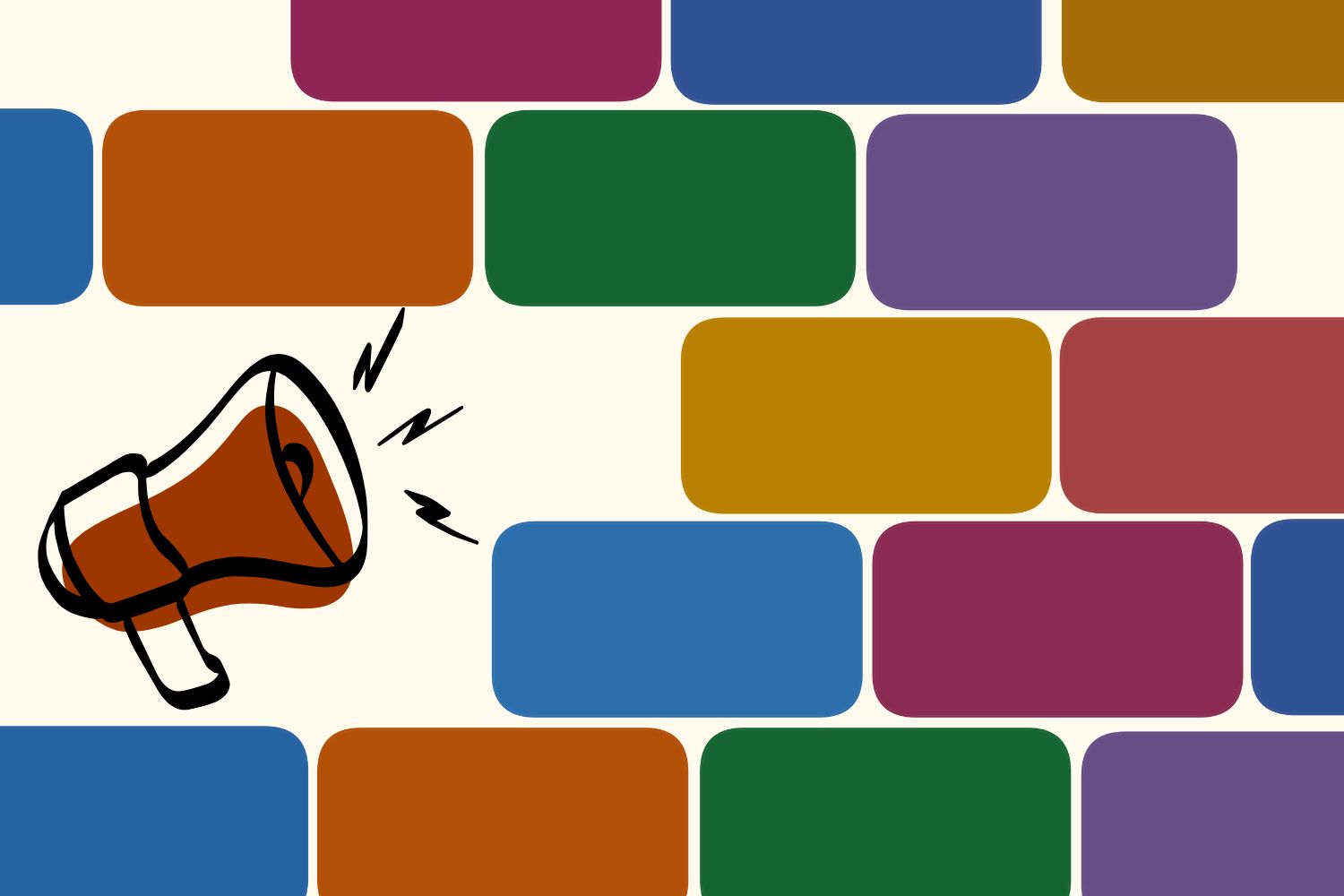
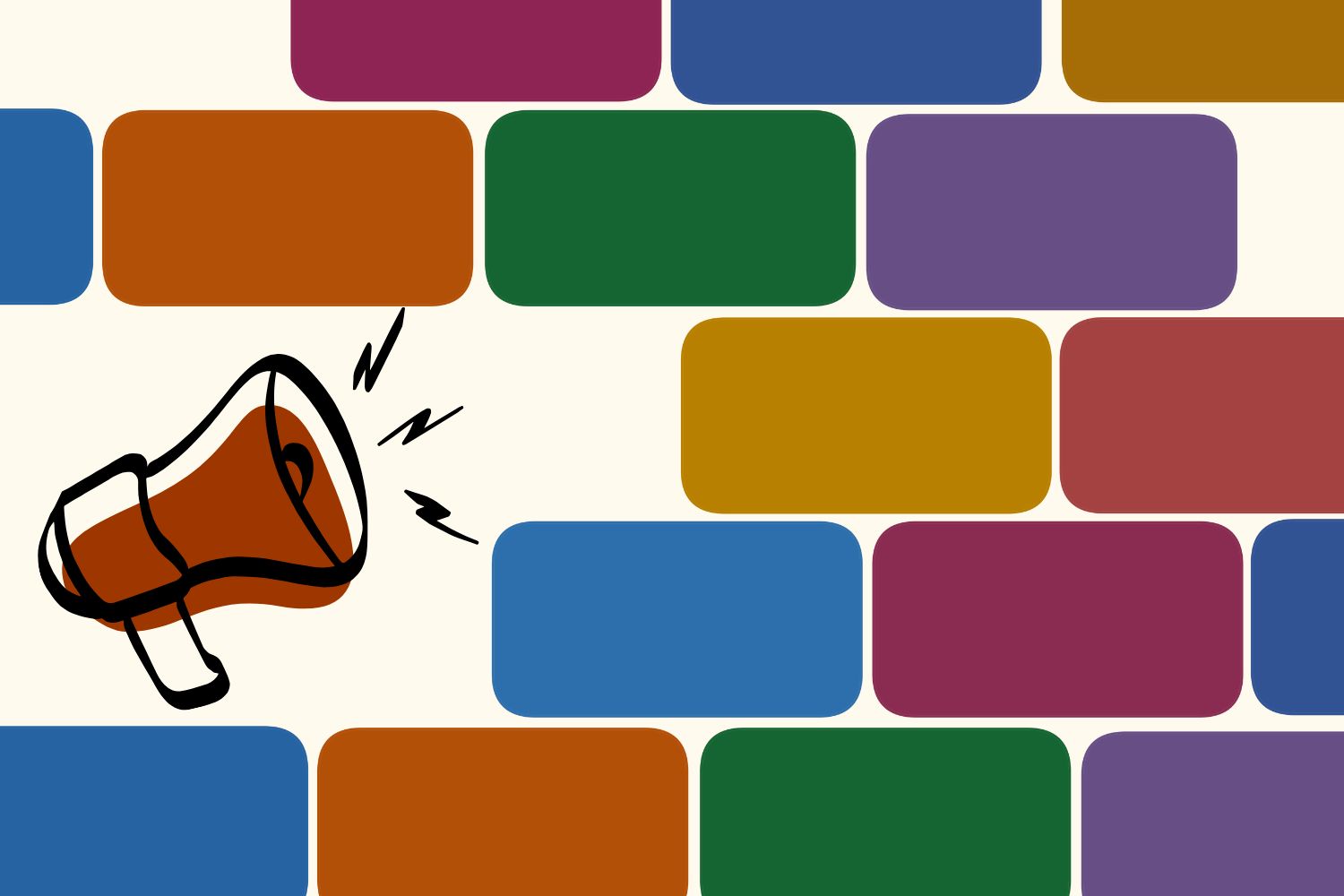
Share